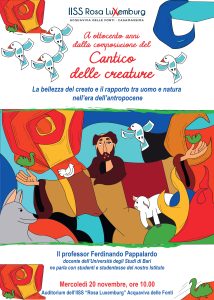 Lo scorso 20 novembre il professor Ferdinando Pappalardo, docente presso l’Università degli Studi di Bari, ha incontrato ragazzi e ragazze del nostro istituto per parlare del “Cantico delle creature” di Francesco d’Assisi e dell’attualità del suo messaggio. Pubblichiamo il resoconto di questo incontro e un video (curato dagli studenti del professionale per la cultura e lo spettacolo) sui lavori realizzati in occasione dell’evento dalle classi terze del liceo artistico.
Lo scorso 20 novembre il professor Ferdinando Pappalardo, docente presso l’Università degli Studi di Bari, ha incontrato ragazzi e ragazze del nostro istituto per parlare del “Cantico delle creature” di Francesco d’Assisi e dell’attualità del suo messaggio. Pubblichiamo il resoconto di questo incontro e un video (curato dagli studenti del professionale per la cultura e lo spettacolo) sui lavori realizzati in occasione dell’evento dalle classi terze del liceo artistico.
LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO… SE IL MONDO SARÀ IN GRADO DI SALVARE LA BELLEZZA
Perché Francesco d’Assisi torna nelle scuole e diventa argomento di attualità? Se n’è parlato il 20 novembre 2024 nell’istituto “Rosa Luxemburg” in occasione dell’ottavo centenario del Cantico delle creature con il prof. Ferdinando Pappalardo.
20 Novembre 2024, 10 del mattino
Cavalletti sormontati da disegni e dipinti, realizzati dalla classe III A del liceo artistico “Rosa Luxemburg” in occasione dell’ottavo centenario della composizione del Cantico delle creature di San Francesco, danno vita al corridoio percorso dalle alunne e dagli alunni mentre si recano vocianti nell’Auditorium, animati da un comune interrogativo: il Cantico delle creature può fornirci la formula per una società migliore?
Ha provato a rispondere il professor Ferdinando Pappalardo, docente di Teoria e storia dei generi letterari e Letteratura italiana presso l’Università degli Studi di Bari ed ex Senatore della Repubblica. Dopo i saluti istituzionali, la parola è passata prima ai ragazzi, che hanno letto a turno il testo del Cantico delle Creature, e quindi al professore, che con il tono calmo ma disinvolto di chi ha una lunga familiarità con la poesia, ha restituito spessore e profondità a ogni parola del componimento.
Il Cantico, l’opera più antica a noi pervenuta in lingua volgare, come ci spiega il professore, ha avuto uno “strano destino”: entrato nel canone, è stato in grado di rompere l’orizzonte d’attesa consueto e di evocare un universo di senso potenziale, che prende le mosse dalla fisica presocratica per proiettarci direttamente nell’antropocene.
Sole, Luna, stelle, acqua, terra, aria e fuoco. Il Cantico è un inno di gloria a Dio, alla grandezza del creato, alla potenza della vita. Diversamente dalla sensibilità del tempo, Francesco non disprezza la materia: conoscere la natura significa conoscere Dio.
La novità introdotta dal Cantico risiede, però, soprattutto nella lingua: non a caso è considerato il primo componimento della letteratura italiana. Infatti, in quel periodo le opere erano ancora scritte in latino, che era la lingua delle persone colte. Se San Francesco avesse scritto la sua opera in latino, sarebbe circolata solo in una cerchia ristretta di intellettuali, che l’avrebbero compresa superficialmente, senza coglierne pienamente il carattere “eversivo”. San Francesco invece scrive in volgare umbro – la lingua degli Spoletini, precisa il professore – per diffondere il suo messaggio a un pubblico il più ampio possibile, soprattutto tra le persone meno abbienti. Francesco voleva però attribuire alla sua opera un valore dottrinale che non era esprimibile in dialetto, perciò arricchisce il lessico, sperimenta una sintassi più complessa, costruisce il testo con strofe e versi di diversa misura, utilizza rime e assonanze.
Il significato del Cantico si articola su diversi piani: dal punto di vista morale, esalta la virtù del perdono, una virtù niente affatto scontata vista la violenza dei conflitti dell’epoca, nota soprattutto per le Crociate. Dal punto di vista intellettuale, rifiuta l’antropocentrismo, cioè quella concezione che mette l’uomo al centro dell’universo. Infatti, per San Francesco, l’uomo è solo una piccola parte della vita sulla Terra, non la matrice, come invece suggerisce la formula biblica secondo cui Dio ci avrebbe creati “a sua immagine e somiglianza”. L’uomo, dunque, non è il padrone del mondo: la natura è una grande famiglia nella quale siamo tutti sullo stesso piano. Dopo ottocento anni, tuttavia, l’umanità non ha ancora assimilato questi concetti: la volontà di dominio dell’uomo sulla natura ha spezzato i legami di fratellanza e ridotto il creato a oggetto di consumo.
Alla fine del suo intervento, entrato nei panni di San Francesco, il professore ha risposto alle domande dell’intervista impossibile preparata per l’occasione dalle studentesse e dagli studenti.
“In quale personaggio attuale si rispecchierebbe in base ai suoi valori morali?” Questa è la domanda più difficile a cui il professore ha dovuto rispondere: “Purtroppo non trovo proprio termini di paragone”, la sua risposta lapidaria. Il mondo è rovinato da noi stessi, proprio perché ruotiamo attorno al significato di antropocentrismo. Mettiamo l’uomo sempre al centro dell’universo, e questo provoca molti problemi. Lo sfruttamento ambientale, lo scioglimento dei ghiacciai, la desertificazione, sono unicamente conseguenza dell’azione degli uomini. Non capiamo che così stiamo rischiando tutti di scomparire, per questo dobbiamo agire per avere un mondo migliore.
Termina così il professore, lasciandoci tutti rapiti dalla sua pacata indignazione, che diventa la nostra e ci spinge a coltivare quello slancio a fare, ciascuno, la propria piccola parte per salvare la bellezza che San Francesco ci ha insegnato a riconoscere e rispettare.
Dunque, perché parlare ancora di Francesco d’Assisi, perché leggere il Cantico ottocento anni dopo? È proprio Francesco d’Assisi che con la sua visione spirituale ci invita a riscoprire il legame profondo tra Dio, la natura e l’umanità e a impegnarci per un mondo più giusto, fraterno e sostenibile. La sua visione di un mondo fondato sull’amore, il rispetto per la natura, la giustizia sociale, la pace, la fratellanza dovrebbe ispirarci, ribadisce Pappalardo. La sua spiritualità ecologica, la sua povertà volontaria, il suo servizio agli altri e il suo impegno per la pace sono modelli che possono guidare la società contemporanea a trovare soluzioni per le sfide globali di oggi.
Classe III C Liceo artistico
Personale scolastico
Docente